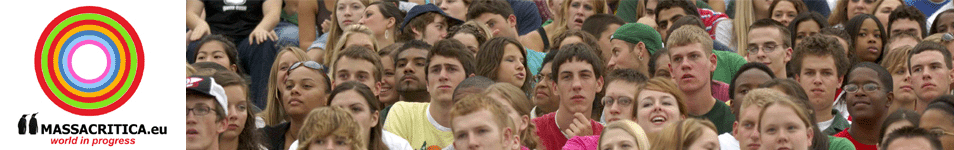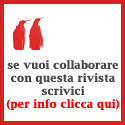“È essenzialmente repulsiva l’idea di una società tenuta insieme unicamente dalle relazioni e dai sentimenti nascenti da interessi pecuniari.” (John Stuart Mill)
Gran parte di ciò che oggi appare scontato risale in realtà agli anni Ottanta: creare ricchezza ad ogni costo, privatizzare, aumentare la forbice tra ricchi e poveri, privilegiare le politiche per la liberalizzazione dei mercati all’insegna di una crescita infinita e disprezzare il settore pubblico.
Se oggi i giovani si sentono un po’ persi e angosciati è perché non vedono davanti a loro obiettivi chiari e raggiungibili e questo dipende molto dall’eredità che gli stiamo lasciando.
Nell’arco di vent’anni si è passati, infatti, da una fiducia ceca nel poter cambiare il mondo, a una assoluta incapacità nel saper definire anche semplicemente da che parte incominciare.
Il così detto 68’ segnò il confine fra una società votata e impegnata nella costruzione del bene comune a una, invece, fortemente individualista.
Questo netto contrasto è oggi facilmente apprezzabile nei due modelli di sociali che dominano gli Stati Uniti da una parte e l’Europa dall’altra.
Nel paese delle stelle e strisce la premessa iniziale è che l’autorità centrale deve essere limitata il più possibile, tant’è che i primi 10 emendamenti della Costituzione Americana precisano che tutto quanto non venga attribuito al governo nazionale deve, in automatico, considerarsi prerogativa dei singoli. Le tasse pagate dai cittadini statunitensi vengono infatti considerate come una cessione di reddito senza compensazione. A nessuno verrebbe mai in mente che siano invece destinate a costruire beni collettivi che altrimenti i singoli individui non potrebbero mai permettersi, come strade, scuole, cure sanitarie ecc, perché l’idea dell’uomo libero e intraprendente, che si fa da solo, continua a essere un must.
In Europa, invece, siamo tutti beneficiari di chi ci ha preceduto e di chi ci curerà quando saremo vecchi e magari anche malati. Tutti gli europei dipendono, infatti, dai servizi pubblici il cui costo è sostenuto da tutti, anche da chi non ha problemi economici e potrebbe tranquillamente pagarsi privatamente quanto gli serve.
In America non è stato, però, sempre così. I programmi del New Deal o della Great Society di Lyndon Johnson vertevano infatti sulle grandi riforme sociali. Da un punto di vista oggettivo, anche se non c’è un sistema ferroviario nazionale, l’America è comunque riuscita a collegare tutto il Paese con un sistema efficiente di autostrade senza pedaggio, nelle città più importanti il sistema di trasporto è pubblico e pubblica è anche l’offerta universitaria di alto livello, i land grant college, forse superiore a quella europea.
Ciò che nel tempo si è “guastata” è l’idea di libertà. Libertà di far soldi o libertà in senso lato. Qualcuno in un lontano passato sarebbe inorridito all’idea che in futuro la società avrebbe deviato verso la pura avidità. Così pensava Condorcet, studiando i primi passi del capitalismo commerciale: “La libertà sarebbe diventata solo la condizione necessaria per la sicurezza delle operazioni finanziarie”.
In verità tutto è già accaduto e l’efficienza, ormai da molto tempo, ha preso il posto della compassione.
Anche nella concorrenza economica è l’operatore che infrange le regole quello che ha la meglio, su altri con maggiori scrupoli etici.
Oggi i mercati sono così liberi perché non devono osservare alcuna regola e questa condizione è la ragione che consente una smodata crescita delle disuguaglianze, per la verità in rapida salita, anche perché agevolata dai governi, che solo negli anni sessanta ne sarebbero stati inorriditi.
Anche i valori etici, sociali e morali delle nuove generazioni sono mutati e la ricerca del lavoro più renumerato ha sostituito quello del lavoro più interessante. La ricchezza esteriore è ora il valore dominante, quello della ricchezza interiore è diventato un peccato di ingenuità.
Torniamo allora nel passato e cerchiamo di capire perché i valori di solidarietà, collettività, bene comune, compassione, fossero così importanti.
Le due guerre mondiali
Mai nella storia umana l’intero mondo fu coinvolto in una serie di catastrofi di portata simile al periodo delle due guerre mondiali.
Ai due conflitti, che bastavano già d’avanzo, si aggiunsero anche rivoluzioni, epidemie, crollo e banca rotta di interi Stati, crollo di democrazie, dittature, pulizie etniche, torture, genocidi: tutto in soli trent’anni! Le uniche democrazie allora sopravvissute furono quelle della Svizzera e della Svezia.
Sicuramente alla fine del 45’ l’umanità pensava a come evitare che quanto era successo non si ripetesse ancora. E fu su questo senso di paura e di incertezza collettiva che John Maynard Keynes elaborò la sua teoria economica.
Keynes era affascinato dall’idea di poter pianificare dall’alto, da un’autorità centralizzata, un sistema di compensazione che risolvesse le inadeguatezze del mercato.
Qualsiasi tentativo di rimettere le democrazie al loro posto doveva infatti confrontarsi con i risultati ottenuti dagli stati autoritari, che secondo il sentimento popolare comune avevano avuto almeno il pregio di aver retto sul lungo periodo sugli interessi della collettività: Hitler aveva rimesso in piedi la Germania, Stalin aveva salvato l’Unione Sovietica dalla Grande depressione e Mussolini aveva fatto arrivare i treni in orario…
Keynes però sapeva anche che un sistema totalitario non era in grado, proprio sul lungo periodo, di evitare guerre e sfruttamento, perciò capiva che occorreva una politica economica che prevenisse possibili depressioni e al tempo stesso pensasse a uno Stato di sicurezza sociale.
Poiché il periodo fra le due guerre aveva dimostrato che tanto il capitalismo quanto il liberismo non erano in grado di vivere l’uno senza l’altro e dal momento che il capitalismo non era stato in grado, in quegli anni di proteggere i propri interessi, l’avrebbe fatto lo Stato liberista. Così nel 45’ i politici democratici si ritrovarono a dirigere a livello pubblico i vertici dell’economia dei loro paesi.
Il consenso fu molto ampio e ad ogni angolo dell’Europa tutti credevano nello Stato, limitando così la libertà del mercato in nome dell’interesse pubblico, e puntando invece su una pianificazione economica e investimenti pubblici su larga scala. E da quel momento in poi, in effetti, il mondo sarebbe stato più al sicuro, protetto da una serie di accordi internazionali e di istituzioni come le Nazioni Unite e la Banca mondiale.
“ Sarà sempre più economico per le casse pubbliche mettere il povero nelle condizioni di comperare il granoturco, piuttosto che abbassare il prezzo del granoturco fino a renderlo accessibile al povero.” (Condorcet)
Le iniquità del capitalismo erano quindi state risolte dalle garanzie di benessere e prosperità future. Infatti in quegli anni le tensioni sociali vertevano sui diritti civili e le leggi razziali, ma non sulla politica sociale tant’è che, sempre in quegli anni, la forbice tra ricchi e poveri si era molto ridotta e il rapporto fra borghesia e democrazia era stato ristabilito, soprattutto perché i ceti medi avevano accesso agli stessi servizi pubblici riservati a lavoratori e poveri: scuole e cure sanitarie gratuite, pensioni pubbliche e sussidi di disoccupazione, tassazione progressiva. Così negli anni Settanta, anche se la borghesia pagava più tasse, disponeva però di un reddito molto superiore a quello di qualsiasi altra epoca.
Grazie a questa maggior equità sociale venne elevato il livello culturale della popolazione e in un certo senso eliminato un classismo alla nascita che decideva chi studiava e chi no, a secondo del ceto in cui si nasceva.
Nella Germania dell’Ovest di quegli anni nacquero allora molte leggi, ancora oggi in vigore, che impongono a banche e società per azioni di tener conto degli interessi dei dipendenti e quindi, se pur con un occhio più attento al profitto, di non perdere mai di vista le conseguenze sociali del loro operato. Nacquero il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale e l’Organizzazione mondiale del Commercio, le Stanze di Compensazione Internazionali, i controlli valutari, le restrizioni salariali e i limiti di prezzo.
Così il mercato stava al suo posto, lo Stato amministrava e governava la vita delle persone e i servizi sociali avevano la precedenza sulle altre voci della spesa pubblica. A quei tempi la fiducia certo non mancava, ma soprattutto era ben riposta. Oggi tutte quelle risorse economiche di ricchezza personale, sacrificate volentieri per fini collettivi, finirebbero nelle mani di burocrati o Stati elefantiaci. Quello che al momento è venuto a mancare è un lavoro di cooperazione che dia come risultato un reciproco profitto. Più una società è uguale, maggiore è la fiducia, maggiore è un comune profilo morale (si è infatti osservato che maggiore è l’eterogeneità culturale ed economica, maggiore sarà la sfiducia nelle istituzioni e nella socialdemocrazia).
Il welfare
“Il welfare consiste nel rimpiazzare il mercato sottraendo alla sua influenza beni e servizi, o in un certo qual modo, nel controllare e modificare il suo operato in maniera tale da produrre un risultato che di per sé non sarebbe riuscito a produrre.” (T. H. Marshall)
In nessuna epoca precedente mai così tanti individui hanno avuto così tante chance di vita.
Ma poi arrivò la generazione degli anni Sessanta, nata e cresciuta in un mondo ricco e generoso di opportunità, che voleva tutto e subito, dimentica del futuro e ignara delle atrocità del passato.
Sebbene storicamente sia ampiamente documentato che nel trentennio socialdemocratico i tassi di crescita economica furono competitivi e quelli di occupazione più che soddisfacenti, l’urbanistica pubblica denunciava, invece, un cambio di passo. Gli edifici di case popolari, sparsi un po’ in tutte le grandi città d’Europa, come quelle progettate da Jeanneret Pierre Le Corbusier, che contenevano centinaia di appartamenti destinati alle grandi masse popolari, erano dei veri e propri obrobi, concepiti senza alcuna sensibilità per la qualità della vita di chi poi ci avrebbe abitato. L’architettura urbana di quel periodo denunciava una nuova manifesta indifferenza della politica alle condizioni di vita dei suoi elettori, e insinuava il dubbio che tutto sommato lo Stato non era poi cosi attento e responsabile verso le classi più deboli della collettività.
Alla fine degli anni Sessanta il divario fra le giovani generazioni e quelle dei loro genitori era maggiore che in qualunque altro momento dei 150 anni precedenti.
Per le vecchie generazioni di quegli anni gli obiettivi condivisi da raggiungere collettivamente erano la giustizia, uguali opportunità e sicurezza economica. Per le giovani generazioni, invece, l’interesse di tutti era stato soppiantato dai bisogni e dai diritti di ognuno: identità sessuale, privata e culturale. Il tema della collettività continuava, certamente, ad essere importante, ma traslato nei paesi più poveri, quelli che oggi chiamiamo Terzo Mondo.
Per le generazioni precedenti quello che andava bene per tutti in definitiva andava bene per ognuno. Viceversa quello che andava bene per un singolo non era scontato andasse bene per un altro. E questo è il punto, quello da cui partire per capire come si sia perduto il vecchio senso comune e si sia instaurato l’attuale “fai quello che ti senti”, in un ottica quasi sempre egocentrica e di promozione esasperata dell’individuo.
“La preservazione della libertà individuale è incompatibile con la piena soddisfazione della giustizia distributiva.” (Friedrich von Hayek)
Isaiah Berlin, nel 1958, riconosceva due concetti di libertà. Libertà positiva: quella dei diritti che solo uno Stato può garantire. Libertà negativa: quella del diritto di essere lasciati liberi di fare come meglio si crede.
A distanza di anni Margaret Thatcher avrebbe, invece, detto “Non esiste una cosa chiamata società. Esistono solo gli individui e le famiglie”.
E poco dopo Ronald Regan avrebbe conquistato il popolo americano affermando “Il Governo non è più la soluzione è il problema”.
Così il nuovo must affermava che una tassazione elevata inibiva la crescita e l’efficienza, che la regolamentazione pubblica soffocava l’iniziativa e lo spirito imprenditoriale e che quindi meno lo Stato interveniva più la società era sana.
Passò anche l’idea di trasferire l’azienda pubblica al privato, per avere una gestione migliore degli investimenti a lungo termine e la fissazione di un prezzo adeguato, ma così facendo si trasferiva la responsabilità pubblica al privato senza alcun vantaggio per la collettività.
Ma come possono i servizi fondamentali di una società conciliarsi con il profitto: il loro scopo è un altro e funzionano bene nella misura in cui lo assolvono e semplicemente non vanno in perdita.
E quando un’Azienda Pubblica viene messa in vendita, non essendo particolarmente attraente per il mercato, perché quasi sempre è in perdita, il suo prezzo viene sicuramente scontato, aggiungendo perdita su perdita per la collettività, che l’ha voluta, finanziata, costruita, mantenuta e valorizzata.
Se a questo svalutazione del prezzo si aggiungono tutti i costi che lo Stato sosterrà per renderla più appetibile al mercato, non ultima la garanzia che solitamente lo Stato dà agli acquirenti che, in caso di gravi perdite, l’impresa privatizzata sarà comunque sostenuta dai fondi pubblici a tempo indeterminato. E se poi questo tipo di azienda partecipata fallisce, lo Stato, che non può permettersi di perdere i servizi fondamentali, è costretto a coprirne le perdite. E si crea, così, un sistema immorale la cui posta in gioco è il bene comune, la collettività. In Nuova Zelanda negli anni Novanta le ferrovie e i traghetti pubblici vennero privatizzati e i nuovi proprietari le svuotarono di tutto. Lo Stato si ritrovò così a sostenere costi altissimi più alti di quelli che avrebbe dovuto sostenere se avesse deciso di investire meglio in quelle aziende quando erano ancora pubbliche.
Ma il problema più grave è ancora un altro: svuotando lo Stato di responsabilità e competenze abbiamo messo in crisi la sua stessa immagine, la sua credibilità.
I nuovi interlocutori per cure mediche e sussidi di disoccupazione sono intermediari privati. Ora l’unico vincolo che lega Stato e cittadini è l’autorità e l’ubbidienza.
Qualunque società che distrugga il tessuto del proprio Stato presto si sfalderà in una polverosa disgregazione di individualismi: tutti contro tutti, tutti da soli, in un tragico deficit democratico, fintamente coperto e mascherato dalla nuova democracy globale della rete che però non riesce a sostituire l’identità di popolo ne a intrecciare legami etici e morali condivisi.
La partecipazione conta
L’eccessiva privatizzazione della vita quotidiana ha frammentato e diviso lo spazio pubblico, fino mettere a rischio la libertà di tutti. Incoraggiando una sempre maggior privatizzazione dei servizi, dello spazio pubblico, delle risorse, spingeremo le nuove generazioni a preoccuparsi solo di soddisfare i propri obiettivi, a consumare tutto fino all’osso, a disinteressarsi completamente o quasi di quel che fa lo Stato e alla fine li escluderemo e ci escluderemo dalla discussione.
Rinunciare a partecipare equivale a spegnere il sentimento di responsabilità collettiva e ad abdicare al proprio diritto di verifica e controllo di quanto in nome nostro, viene fatto e deciso, e quando capiterà che diremo che non siamo d’accordo nessuno sarà lì ad ascoltarci.
Oggi questo pericolo è ancora più insidioso perché i territori si allargano verso la globalità e viene sempre più a mancare il confronto diretto, l’appartenere a una comunità, a una città, a una popolazione, fino all’estraneità perfino dal pianeta, che la concentrazione urbana sta sbiadendo e svuotando di significato.
Questo deficit democratico si accompagna non solo a una diffidenza congenita verso la politica e i loro rappresentanti, ma ci abitua a vivere come semplici consumatori.
Ci incontriamo occasionalmente solo per affrontare e condividere interessi economici e non collettivi.
Ci preoccupiamo e ci spendiamo al massimo, solo per appagare le nostre individualità, che sempre più spesso aspirano a soddisfare nuovi consumi e solo l’idea di ricercare e costruire valori etici e morali ci annoia, ci appesantisce, ci tarpa le ali.
Manchiamo di ideali, sogni, speranze e compassione e accettiamo pigramente che la politica si limiti ad una mera contabilità sociale, dimentichi di ricercare e mettere in atto strumenti e servizi capaci di proteggere la maggioranza più debole e lasciando, invece, che la minoranza più forte e ricca ottenga ancor più privilegi.
“Non è sufficiente che lo stato delle cose che cerchiamo di promuovere sia migliore dello stato delle cose che lo ha preceduto; deve essere sufficientemente migliore da compensare i mali della transizione.” (Keynes)
E allora, senza invocare alcuna rivoluzione, sarebbe sufficiente tornare a discutere, anche dissentire, perché una ricerca esasperata del consenso, salvo portare voti in prima battuta, svuota la democrazia della sua stessa sostanza e in seconda battuta la elimina.
Un conformismo ad oltranza, dove opposizione e malcontento non sono consentiti, se non entro limiti già strutturati, spegne la capacità di reagire in modo energico e creativo alle nuove sfide e cresce politici pusillanimi.
Il dissenso nasce dalla base della piramide sociale, alla ricerca di una miglior condizione di vita ed è normale che metta in discussione l’assetto sociale che l’ha messa o lasciata in difficoltà.
Il compito sociale di dissentire in maniera articolata nel passato veniva esercitato dagli intellettuali. Oggi il dibattito sul come governare la società è stato delegato alle think tanks o a specialisti, dal cui perimetro resta esclusa la maggior parte della collettività, sia in termini di spazi fisici sia in termini di alfabetizzazione culturale. Si è quasi tornati a una sorta di medioevo la cui liturgia è accessibile solo a pochi iniziati, per tutti gli altri basta la fede.
L’errore che fanno molti giovani è quello di cercare di cambiare il mondo passando solo dalle associazioni umanitarie. In realtà tutto il sistema è stato costruito sul perno della politica e da lì quindi bisogna ripartire, impegnandosi di nuovo per gestire la cosa pubblica. Se i giovani non raccoglieranno questa sfida lasceranno la società, i loro vecchi, loro stessi e i loro futuri figli nelle mani di pusillanimi venali mediocri yesman.
La presa di coscienza di moltissimi giovani che hanno partecipato e seguito la conferenza di Copenaghen del 2009 sul Clima, ha dato loro una chiara visione dell’urgenza e delle implicazioni del riscaldamento globale. Inutile sfogarsi e disperdersi in mille rivoli. Alla fine le istituzioni democratiche vanno salvate, ma ripulite dalle derive della vile pecunia e riportate al loro ruolo originario che è quello di impegnarsi per il bene della collettività. Occorrono strumenti e leggi nuove che consentano di vigilare sull’operato di chi viene eletto e di correggere il tiro se lo stesso devia dal suo mandato.
Quanto siamo disposti a pagare per avere una società giusta? Dobbiamo in primo luogo accordarci sul significato da dare a società giusta e comportarsi bene.
Libertà ed eguaglianza in senso lato hanno portato a creare ricchezza senza limiti a scapito dell’ambiente e dell’umanità, che hanno, invece, limiti precisi.
“Il successo della democrazia nel dopoguerra poggiava sull’equilibrio fra produzione e ridistribuzione, regolamentato dallo Stato. Con la globalizzazione, questo equilibrio si è rotto. I capitali sono diventati mobili: la produzione si è trasferita oltre i confini nazionali sottraendosi alla ridistribuzione pubblica. La crescita ormai si contrapporrebbe alla ridistribuzione, il circolo virtuoso si sarebbe mutato in circolo vizioso.” (Dominique Strauss-Kahn)
Siamo finiti in una nuova narrazione, quella del capitalismo globale integrato, il cui mantra è crescita è bello, e a cui si accompagna una competizione economica globale e l’esclusione della politica come ambito di scelta, che lascia invece il posto alle regole casuali della natura.
È vero che le diseguaglianze tra i Paesi stanno diminuendo, ma stanno però aumentando le disparità di ricchezza e povertà al loro interno.
E allora quello che resta a difesa della sicurezza, fisica ed economica delle popolazioni è lo Stato, l’unico che può frapporsi fra gli individui e tutto ciò che non è statale come Banche e Multinazionali.
Grazie agli Stati si potrà cercare di accrescere di importanza gli organismi transnazionali.
La stessa Angela Merkel è tornata a sposare lo Stato sociale di mercato contro gli eccessi della finanza globale.
Liberati dall’idea del Novecento che vedeva lo Stato come la soluzione migliore a qualsiasi problema, ora dobbiamo liberarci dall’idea che lo Stato sia, fra quelle disponibili, l’opzione peggiore, e guardare a lui non solo come riparatore di tutti i cocci rotti, ma anche come argine delle conseguenze negative di un profitto che ormai da troppo tempo corre a briglie sciolte, e la cui velocità è diventata incontrollabile perfino a chi la comanda.
In mancanza di istituzioni credibili e affidabili i servizi verranno sempre più affidati a privati e come accadde nel passato la promessa di stabilità si confonderà con quella di protezione e sicurezza. Sarà la paura a guidare la scelta di voto delle masse, che saranno tentate da un sistema ordinato e prevedibile, piuttosto che da uno Stato democratico allo sbando: la posta in gioco è alta. La democrazia è un’opportunità, nata pochissimo tempo fa, di autentica dignità per ogni essere umano, che potrebbe non ripresentarsi.
Perciò stiamo attenti a non lasciarci tentare dal distruggere tutto, e in fretta, in nome di un progetto moderno e universale. Si possono fare solo miglioramenti graduali che guardando al passato capiscono come tracciare il futuro. L’esplosioni nucleari hanno lasciato solo morte e devastazione.
di Adriana Paolini
Bibliografia:
Guasto è il mondo, Tony Judt.