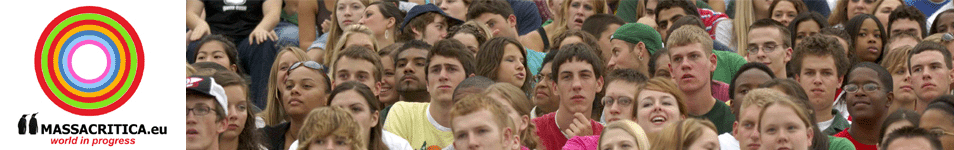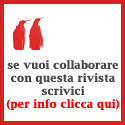“Uccidere è proibito, quindi tutti gli assassini vengono puniti, a meno che non si uccida su larga scala e al suono delle trombe.”
Con questa citazione tratta dal Dizionario filosofico di Voltaire si apre la prima e surreale scena di The Act of Killing. Dalla gigantesca bocca di una struttura a forma di pesce escono, danzando e cantando, sei ninfe con abiti dorati che si stagliano dall’azzurro delle acque lacustri sullo sfondo. Della citazione bisogna da subito servirsi come chiave di lettura, come strumento per addentrarsi in una realtà che ci sembrerà paradossale. Proprio questa è l’idea che guida gli otto anni di produzione: indagare la surrealtà di cui è permeata la società indonesiana, in cui i carnefici delle purghe anticomuniste degli anni ’60 sono tutt’ora gli uomini al potere, acclamati come eroi nazionali. Uomini che non rifiutano di raccontare quello che hanno fatto, ma, anzi, orgogliosamente, lo mettono in scena per consegnarlo alla storia e al grande pubblico.
A guidarci in questo viaggio attraverso la memoria e l’immaginazione dei protagonisti dovrà essere la consapevolezza che la storia è quasi sempre scritta dai vincitori: solo la possibilità di assumere un punto di vista diverso consente di rivederla e rielaborarla.
The Act of Killing è un film-documentario uscito nel 2012 e diretto da Joshua Oppenheimer, da Christine Cynn e da un co-regista indonesiano rimasto anonimo. Caso unico per il suo genere, ha collezionato più di sessanta premi ed è stato candidato all’Oscar nel 2014 per il miglior documentario. Tra i produttori esecutivi figurano anche Werner Herzog ed Errol Morris.
Cinquant’anni fa: i massacri indonesiani del 1965-66
Il primo Ottobre 1965 vennero assassinati sei generali nell’area di Jakarta. Ad approfittare della situazione caotica fu il generale di destra Suharto, che assunse il controllo dell’esercito. L’allora presidente Sukarno, fondatore del Movimento dei paesi non allineati e leader della lotta contro l’impero coloniale olandese, si rifiutò di prendere una posizione chiara rispetto all’accaduto. Suharto poté così annunciare che il colpo di stato era fallito ed incolpare, con il sostegno delle forze militari, il Partito Comunista Indonesiano (PKI), loro dichiarato nemico. Seguì una campagna di propaganda che convinse gli indonesiani e l’audience internazionale che gli assassinii erano stati commessi da membri del PKI contro gli eroi della guerra d’indipendenza e per destituire il presidente Sukarno (nonostante il partito avesse fermamente sostenuto la sua presidenza e avesse avuto un ruolo di rilievo nelle guerre di liberazione). La smentita del PKI non ebbe rilevanti effetti. In un clima di emergenza nazionale Suharto usurpò gradualmente l’autorità di Sukarno fino a diventare presidente de facto dal Marzo 1966 e per il successivo trentennio.
Negli anni precedenti ai massacri, il PKI, con un notevole supporto popolare e circa tre milioni di membri, era il più forte partito comunista dopo quello dell’Unione Sovietica e della Cina.
Dopo il colpo di stato del 1965, chiunque si opponesse alla dittatura militare poteva essere accusato di comunismo. Così accadde a membri del sindacato, contadini senza terra, abitanti di etnia cinese e intellettuali, in generale a chiunque lottasse per una redistribuzione dei beni nel periodo successivo al colonialismo. L’esercito si servì di civili per perpetrare i massacri, formando organizzazioni paramilitari e recrutando gangster. In meno di un anno e con il diretto aiuto dei governi occidentali più di un milione di presunti “rossi” vennero uccisi. Da allora il governo indonesiano celebra questo sterminio come una guerra patriottica, e i carnefici come i suoi eroi, ricompensandoli con potere e privilegi.
Genesi del documentario e note di regia
Nelle numerose interviste rilasciate, Oppenheimer racconta l’evoluzione del progetto durante gli otto anni di lavoro. Soggetto e metodo adottato, infatti, vennero modificati più volte.
Il documentario iniziò lavorando a stretto contatto con i sopravvissuti, cercando di rappresentare le memorie degli orrori del 1965 e il regime di paura, violenza e corruzione costruito sulla celebrazione dei massacri. I sopravvissuti stessi chiedevano di essere filmati, così da poter mostrare che cosa significasse vivere vicino agli ex-capi degli squadroni della morte ancora al potere e con il timore che quanto avvenuto potesse ripetersi da un momento all’altro. In poco tempo l’esercito, stazionato in ogni villaggio, scoprì che cosa stava succedendo e proibì agli abitanti di essere ripresi. Furono allora i superstiti stessi a suggerire di filmare i carnefici, quasi certi che avrebbero volontariamente rivelato i loro crimini. “Non sapevo se fosse sicuro approcciarli, ma quando lo feci, si mostrarono da subito orgogliosi e ci raccontarono gli orribili dettagli delle loro stragi, spesso con un sorriso e davanti alle loro famiglie, perfino ai loro nipoti. In questo contesto di follia, mi sentii come se stessi camminando in Germania quarant’anni dopo l’olocausto, per scoprire i nazisti ancora al potere”, afferma Oppenheimer.

Come appare dalle prime scene, gli assassini si spinsero ben oltre il semplice racconto delle loro azioni. Si offrirono volontariamente di portare la troupe nei luoghi dove perpetrarono le uccisioni di massa, e le ricostruirono senza alcuno scrupolo. Degli ufficiali, addirittura, si curavano che il suono delle registrazioni non venisse disturbato.
Per comprendere le ragioni di questi comportamenti, di un regime il cui potere è fondato su una strage e la sua trasparente e fiera narrazione, i registi chiesero agli esecutori di ricreare le scene dei massacri nella maniera che desiderassero, riprendendo anche le loro fasi di pre-produzione, incluso il casting, le riunioni per la sceneggiatura, le prove costume e le sedute di make-up.
L’obiettivo di quest’innovativa forma di documentario, che combina le rappresentazioni delle stragi da parte di chi le ha davvero perpetrate e il loro making-of, è esplorare l’area di intersezione tra immaginazione e violenza, per denunciare gli schemi persecutori tutt’ora in atto nella società indonesiana.
Dalla pellicola alla storia
I personaggi centrali del documentario sono Anwar Congo, carnefice nel 1965, ed Herman Koto, gangster e uno dei leader dei paramilitari.
Da giovani passavano il tempo nei pressi dei cinema, controllavano il mercato nero dei biglietti e usavano questi luoghi come base per operazioni criminali più ampie. Quando il governo indonesiano venne sovvertito dai militari, Congo e i suoi amici vennero promossi da semplici fuorilegge dediti al bagarinaggio a capi degli squadroni della morte, per la loro provata attitudine alla violenza e il loro odio verso i comunisti, che in quegli anni boicottavano i film americani – un vero danno per i loro affari, dal momento che le pellicole statunitensi erano le più richieste al botteghino.
Oggi questi gangster sono riveriti come fondatori della Gioventù Pancasila, una delle più grosse organizzazioni paramilitari indonesiane (con circa tre milioni di membri) nata dai gruppi armati del 1965. Tra i suoi leader figurano anche ministri del governo.

Il comunismo non verrà mai accettato qui, perché abbiamo così tanti gangster, ed è una buona cosa. La parola “gangster” viene dall’inglese. “Uomini liberi”. I malviventi vogliono libertà di azione, anche se stanno sbagliando… Ma se sappiamo come lavorare con loro tutto quello che dobbiamo fare è dargli una direzione. (Syamsul Arifin, Governatore del Nord Sumatra)
Anwar Congo e i suoi amici erano grandi fan di John Wayne, James Dean, Al Pacino e altre stelle hollywoodiane. Ne riprendevano esplicitamente lo stile e ispiravano i loro metodi di tortura a quelli dei loro idoli: in una sorta di abbattimento della quarta parete, si sentivano come gangster saltati fuori dallo schermo. I diversi generi cinematografici potevano portarli ad approcciare le stragi in modi diversi. “Uno degli esempi più scioccanti fu, come, dopo aver visto un allegro musical di Elvis Presley, potessero sentirsi allegri nell’uccidere”, racconta Oppenheimer, sconcertato dalla profondità della relazione tra questi assassinii e il cinema. L’idea di essere ripresi, dunque, non era vissuta come una testimonianza per un documentario, significava, invece, recitare nel genere di film che amavano.
Si origina così uno spazio in cui questi “attori” possono mettere in scena i loro crimini, utilizzando i codici dei loro generi cinematografici preferiti (western, noir, musical). All’interno della rassicurante cornice di finzione filmica, Congo e i suoi sodali dispongono della massima libertà: possono dirigere i loro “colleghi”, fargli interpretare il ruolo delle vittime, e recitare a loro volta nei panni delle vittime.

I registi iniziarono ad accorgersi dell’esistenza di un profondo legame fra la performance e l’atto di uccidere. Una pratica di alienazione che rese possibile a questi esecutori assentarsi dalle scene dei loro crimini mentre li commettevano. Oppenheimer spiega in un’intervista che Anwar Congo venne scelto come personaggio principale perché in qualche modo i suoi tormenti erano prossimi alla superficie. Incontrandolo, intuì che forse il vantarsi delle sue azioni non era un segno d’orgoglio, ma, all’opposto, poteva essere uno sforzo di difesa per convincersi che quello che aveva fatto fosse giusto, così da non doversi riconoscere come assassino di centinaia d’uomini. Lo confermano le inquietudini che racconta in varie parti del film, un residuo coscienziale che comparirà gradualmente sul set della sua consapevolezza morale: “Lo so che i miei brutti sogni vengono da quello che ho fatto… uccidere gente che non voleva morire”. E ancora: “Quella è la fonte dei miei incubi, sono sempre osservato da quegli occhi che non ho chiuso”.
Una parte fondamentale del documentario sono i momenti in cui vengono mostrate le scene più dure e dense di significato ad Anwar Congo e ai suoi sodali. Guardandole, guardandosi nell’atto di uccidere, alcuni intravedono le loro colpe e la brutalità priva di fondamento dei loro crimini, altri si preoccupano dei possibili effetti che i contenuti prodotti avrebbero causato sulla storia e, di conseguenza, sulla loro immagine pubblica.
“Vedere queste scene rendeva Anwar più interessato e coinvolto nel lavoro, così capii gradualmente che attraverso il processo filmico stava seguendo un percorso parallelo, interiore, nel quale cercava di affrontare il significato di quello che aveva fatto”, afferma Oppenheimer. In questo modo, inscenando le sue memorie delle stragi e riguardandole in video, Congo cerca entrare in contatto con le orribili immagini che lo visitano negli incubi.
L’intento del documentario non è quello fornire una seduta psicoterapeutica ai personaggi e condurli ad una riconciliazione con loro stessi, com’è stato erroneamente notato. Altrimenti la sua tensione storica e sociale verrebbe notevolmente smorzata. Tuttavia è innegabile che i personaggi, parallelamente e inconsapevolmente, siano coinvolti in uno psicodramma. In questo consiste la grande intuizione del film, utilizzare la rappresentazione, la messa-a-distanza, per produrre un momento di autocoscienza, che da individuale può ergersi a collettiva e quindi storica.

Una delle ultime sequenze mostra Anwar Congo nel ruolo di vittima. In un’ambientazione da film noir viene interrogato, torturato e strangolato da uno dei capi degli squadroni della morte (Herman Koto). Visibilmente sconvolto, come in uno stato di trance in cui è venuto meno lo iato tra se stesso e il personaggio interpretato, non riesce a proseguire nella parte e deve fermarsi. La linea che separa recitazione e realtà sfuma progressivamente sia nel documentario, sia nell’interiorità dell’attore-uomo. Riguardando queste scene a casa, in lacrime, si domanda: “Ma la gente che ho torturato ha provato quello che ho provato io? Posso capire cos’hanno provato le persone che ho torturato. Perché qui la mia dignità è stata distrutta… e poi arriva la paura, lì e subito. E il terrore ha preso il controllo del mio corpo. […] Ho peccato? L’ho fatto a così tanta gente, Josh. Mi sta tutto tornando indietro?”.
Alla fine del film rivisita la terrazza dove ci aveva portati all’inizio per mostrarci con fierezza il luogo dei massacri e i suoi metodi di tortura, ma con una consapevolezza diversa. Unica vera figura tragica, al termine della parabola emotiva disegnata sulla – e grazie alla – pellicola, va in contro ad una catarsi psicodrammatica. Nel suo ultimo soliloquio il rimorso si rende tangibile: la nausea e il senso di soffocamento che prova, segnalano il crollo di una morale basata su una narrazione storica distorta. Una menzogna creata, e continuamente raccontata, per garantire l’impunità e la sussistenza di un regime fondato su un massacro.
In questo modo l’arte, in una feconda interazione col reale, si fa veicolo per la verità, rivelando contemporaneamente il senso conoscitivo che possiede e riuscendo a farci vedere le cose dai diversi punti di vista.

Senti, se questo film avrà successo, renderà nulla tutta la propaganda sui comunisti che erano crudeli. E farà vedere che eravamo noi quelli crudeli! […] Sono 40 anni fa… quindi ogni procedimento penale è in prescrizione. Non è paura. E’ tutto un problema di immagine. Tutta la società dirà: “L’avevamo sempre sospettato. Hanno mentito sui comunisti e la loro crudeltà.” Non è un problema nostro è un problema per la storia. Tutta la storia verrà invertita. (Adi Zulkadry, carnefice nel 1965, sulla sinistra)
Nei titoli di coda scorre una lunga lista di “Anonymous”, tra cui anche il co-regista. Si tratta di tutti gli indonesiani, circa sessanta, che hanno collaborato alla realizzazione del film e di cui non potrà essere mostrato il nome finché non avverrà un cambiamento politico.
Riflessioni sul documentario
Per meglio comprendere il metodo filmico sviluppato e la sua originalità conviene addentrarsi nel pensiero di Joshua Oppenheimer riguardo alla forma documentaristica. In numerose interviste dichiara di ispirarsi al lavoro di Jean Rouch, etnologo e regista francese, considerato uno dei fondatori del cinéma vérité. Secondo questo stile cinematografico ogni volta che si filma qualcuno, si crea una realtà in cui è coinvolto tanto il soggetto ripreso, quanto il regista. La cinepresa non cattura solo ciò che già c’è, poiché nel momento in cui viene introdotta modifica la realtà in cui è inserita. Dalla parte opposta si schiera il direct cinema. Qui la cinepresa viene intesa come una finestra trasparente da cui si osserva una realtà preesistente. Il regista deve lavorare senza nessun tipo d’interazione, come fosse una mosca su una parete – da cui il nome dello stile, fly-on-the-wall -, cosicché i soggetti possano dimenticarsi della sua presenza. Il punto di forza di questa tecnica è che induce lo spettatore ad abbandonare i suoi sospetti e percepire gli eventi come reali. Tuttavia, come osserva il regista di The Act of Killing, “Quello che davvero accade è che la troupe e le persone che vengono filmate collaborano per simulare una realtà in cui fingono che la cinepresa non ci sia”. Nessuno dimentica di essere ripreso. Tutti i documentari contengono prove recitative, dal momento che i soggetti iniziano a recitare nei panni di loro stessi. Di conseguenza il direct cinema crea solo l’illusione di documentare la realtà. “Credo che il cinéma vérité, al contrario, consista nel dare alle persone lo spazio di esibirsi davanti alla camera, di rappresentarsi, e ciò rivela il modo in cui le persone si immaginano e quale senso diano al loro mondo. […] Nel cinéma vérité si cerca di rendere visibile qualcosa di invisibile – il ruolo della fantasia e dell’immaginazione nella vita quotidiana”.
Anche i produttori esecutivi sono in linea con questo pensiero. Secondo Herzog il documentario deve allontanarsi dall’idea di film basato sui fatti, su puri fatti: “Questi, di per sé, non costituiscono la verità. Sarebbe un grande errore. Altrimenti l’elenco telefonico di Manhattan sarebbe il libro dei libri. Quattro milioni di voci, tutte fattualmente corrette”.
Secondo Erroll Morris, il documentario è una forma d’arte in cui si cerca di comunicare qualcosa intorno al mondo reale. Vi è sicuramente una componente giornalistica, ma si tratta, più propriamente, di giornalismo unito a qualcosa che va oltre (oltre l’esposizione dei meri fatti). E a proposito di The Act of Killing afferma: “Una delle cose più straordinarie del documentario è la possibilità di reinventarne di continuo forma e significato – e Oppenheimer ha fatto esattamente questo”.
Il ruolo dell’Occidente
The Act of Killing ha vinto il premio BAFTA del 2014 per il miglior documentario. Nel video pubblicato online è stata tagliata una parte – scomoda evidentemente – dell’intervista a Joshua Oppenheimer seguita al discorso di accettazione: “Mi preme sollecitare tutti noi ad un momento di riflessione, per riconoscere che siamo molto più vicini ai carnefici del 1965 di quanto ci piaccia credere. Il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno aiutato a progettare questo genocidio, per decadi hanno entusiasticamente supportato la dittatura militare che ottenne il potere attraverso questo sterminio. In futuro non potremo avere una relazione etica e costruttiva con l’Indonesia (come con molti altri paesi del Sud del mondo), finché non riconosceremo i crimini avvenuti in passato, e le nostre responsabilità nell’aver supportato, partecipato, e, alla fine, ignorato questi crimini”. In altre interviste spiega più dettagliatamente che gli Stati Uniti fornirono aiuti finanziari alle forze militari e agli squadroni della morte, armi, un sistema radio con cui l’esercito poté coordinare le uccisioni nel vasto arcipelago, e “liste nere”. Agenti della CIA e funzionari del Dipartimento di Stato registravano migliaia di nomi di figure pubbliche indonesiane considerate nemiche del regime, che gli Stati Uniti volevano morte, e li consegnavano al governo indonesiano. L’annientamento del PKI rientrava tra gli obiettivi americani della guerra fredda e significava assicurarsi che i comunisti non arrivassero al potere nella nazione più grande e strategicamente importante del Sudest asiatico, dove gli Stati Uniti stavano già combattendo una guerra (non dichiarata) in Vietnam.
In conclusione, Oppenheimer ci fa riflettere su come la storia recente dell’Indonesia – ma non solo – e le sue attuali condizioni sociali siano strettamente connesse alla nostra vita di tutti i giorni: ”Noi occidentali dipendiamo quotidianamente da quei regimi che fanno in modo che tutto ciò che compriamo sia economico, utilizzando una narrazione storica distorta per terrorizzare e sottomettere le persone a questo scopo, così che il costo umano della produzione non sia incluso nel prezzo di vendita. Da una parte sembra un mondo a noi estraneo; dall’altra è una porzione essenziale della nostra realtà – il suo lato nascosto”.
di Federico Fantelli
Linkografia:
www.youtube.com/watch?v=QwuJaxs9KDE – Trailer italiano
www.youtube.com/watch?v=hHGbb64YxAk – Intervista BYOD
www.youtube.com/watch?v=BR8CtYk9GU0 – Premiazione BAFTA
www.youtube.com/watch?v=LLQxVy7R9qo – Intervista a Werner Herzog ed Errol Morris
http://www.filmcomment.com/blog/interview-joshua-oppenheimer-the-act-of-killing/