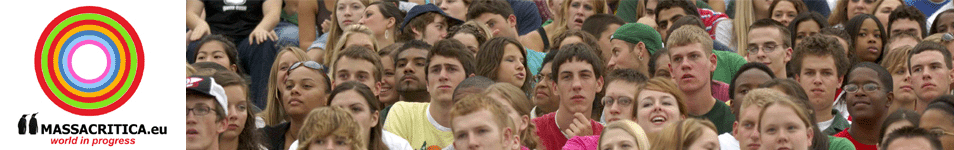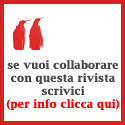A quindici anni dall’ultima vittoria negli Usa con La vita è bella di Roberto Benigni, gli stessi quindici anni che hanno separato Amarcod di Federico Fellini (1975) da Nuovo cinema paradiso di Giuseppe Tornatore (1990), il cinema italiano torna a trionfare agli Oscar 2014, dopo il più lungo digiuno di statuette dorate, con La grande bellezza, di Paolo Sorrentino.
Appena quarantatreenne, a poco più di dieci anni dal suo esordio nel lungometraggio, il regista napoletano colleziona una serie di successi, di respiro progressivamente internazionale. A portarlo alla vittoria un ritratto dell’Italia: una narrazione fatta di inquadrature e musiche, in una sequenza apparentemente disordinata, che trae la sua forza dalla potenza delle immagini. Una Roma vuota è la scenografia di questo grande teatro. Niente code di auto, clacson e folle di turisti chiassosi. Un vuoto che riflette quello dei personaggi che si agitano al suo interno. Sorrentino racconta di chi vive una vita fatta di eccessi, di fuochi d’artificio, e guarda con stupore alla normalità. Porta sullo schermo l’amara bellezza di questa condizione, “La dolce e tremenda sensazione di non andare da nessuna parte”, nota a chi si muove al ritmo della grande città.
Il senso di smarrimento, la sensazione di stare sprecando il proprio tempo, la fatica di vivere nonostante il privilegio, la consapevolezza della propria miseria e l’accettazione rassegnata dei propri fallimenti. E allo stesso tempo l’inconsapevolezza di chi cita nomi e cose di cui ignora il significato, di chi vuole pronunciarsi su tutto e interviene rigorosamente a sproposito, di chi crede di potersi ritenere artista dando “le capate nel muro”, della perdita di senso delle parole e dell’ostentazione di una falsa immagine di sé, che nasconde le debolezze e la disperazione.
La vita di questi personaggi si consuma nella notte. L’espediente usato dal regista, gli consente di mettere in scena il contrasto tra il patetico, la volgarità che caratterizza certi ambienti, e il sublime di un’alba su Roma, quando tutto termina. Reso attraverso la geniale capacità, propriamente partenopea, di raccontare il dramma attraverso l’ironia, senza mai confondersi con la leggerezza. Dietro ognuno di loro c’è l’esplorazione di un mondo. Ciascuno diverso, ma tutti accomunati da un esasperata contraddizione interna: una giornalista di elevata statura morale, costretta nel corpo di una nana, un cardinale che ne sa molto più di cucina che di fede, una spogliarellista dall’animo nobile e, il protagonista, un uomo destinato alla sensibilità che finisce per essere il re dei mondani: il disincantato Jep Gambardella e la sua nostalgia di una giovinezza ingenua, fatta di grandi aspettative. Arrivato a Roma all’età di 26 anni scrive il suo unico romanzo, L’apparato umano, prima di precipitare, come egli stesso narra, nel vortice della mondanità. Un vortice fatto di feste e discorsi vuoti. Ha così inizio lo smarrimento della propria identità e la riflessione sulla futilità e l’insensatezza della propria esistenza, fino al punto di non riuscire più a trovare le parole per raccontare la realtà.
Mi chiedono perché non ho più scritto un libro. Ma guarda qua attorno. Queste facce. Questa città, questa gente. Questa è la mia vita: il nulla. Flaubert voleva scrivere un romanzo sul nulla e non ci è riuscito: dovrei riuscirci io?
A irrompere nella statica, e a tratti passiva, condizione di protagonista e spettatore di questo spettacolo patetico, la notizia della scomparsa di Elisa, il suo primo, e probabilmente unico, amore.
Inizia qui un viaggio nella memoria e nella testa del protagonista, che lo spinge a un profonda meditazione su stesso e sul mondo che lo circonda. Un susseguirsi di domande che restano inevase, e una timida speranza che si fa largo tra di esse, quando dopo anni di silenzio Jep valuta la possibilità di tornare a scrivere.
È tutto sedimentato sotto il chiacchiericcio e il rumore. Il silenzio e il sentimento. L’emozione e la paura. Gli sparuti incostanti sprazzi di bellezza. E poi lo squallore disgraziato e l’uomo miserabile. Tutto sepolto dalla coperta dell’imbarazzo dello stare al mondo. Bla. Bla. Bla. Bla. Altrove, c’è l’altrove. Io non mi occupo dell’altrove. Dunque, che questo romanzo abbia inizio. In fondo, è solo un trucco. Sì, è solo un trucco.
di Teresa Gargiulo