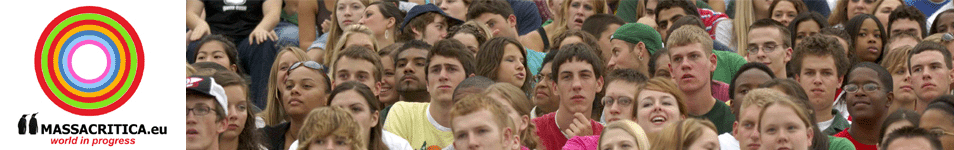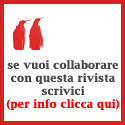Brocche, trappole per topi, ferri arricciacapelli, mestoli, fornelli, pentole, bidoni: oggetti di vita quotidiana realizzati riciclando tutto ciò che popola una delle baraccopoli più affollate dell’Africa: Mathare Nairobi.
Cos’è il design?
Il termine “design”, diffuso in Italia dalla metà del secolo scorso, è l’abbreviazione dell’espressione inglese industrial design (disegno industriale) che si riferisce alla progettazione di oggetti che si producono in serie attraverso le filiere industriali; sono oggetti di uso quotidiano, complementi d’arredo, come lampade, sedie, utensili ed elettrodomestici. La progettazione di questi prodotti è il risultato di una sintonia perfetta tra forma e funzione, che non predilige uno solo dei due aspetti, ma li valuta e li sviluppa parallelamente nell’iter progettuale, in modo che risultino totalmente integrati nel prodotto finale; è un’integrazione tra l’aspetto tecnologico-funzionale e la qualità estetico-formale.
Se un oggetto già esistente viene solo “rivisitato” a livello estetico, senza apporti tecnici né funzionalità significativi, si può parlare di redesign o styling, ossia di un’azione di «cosmesi» – così definita dal critico d’arte Gillo Dorfles – tesa a rinnovare l’immagine dell’oggetto per incentivarne il consumo, senza formulare però un nuovo progetto.
Il design abbraccia anche la relazione tra il prodotto, il suo consumatore, l’intero progetto di un prodotto e lo studio del suo processo costruttivo, compreso il suo ciclo di vita. Il design di un manufatto è quindi il risultato dell’analisi di tutte le caratteristiche progettuali che definiscono il prodotto stesso e che racchiude in sé un insieme di studi egonomici, di utilizzo, la pre-produzione, l’impatto ambientale, la dismissione, i costi, la scelta dei materiali e delle loro proprietà, dei rivestimenti, le proprietà meccaniche e strutturali, ecc.

 Gli Slum e le nuove povertà urbane.
Gli Slum e le nuove povertà urbane.
Nelle pagine de La città della gioia, di Dominique Lapierre, si legge: “Su uno spazio appena tre volte più grande di un campo sportivo si accalcavano più di settantamila abitanti, vale a dire circa diecimila famiglie geograficamente ripartite a seconda della loro religione.[…] [La Città della gioia] deteneva il triste primato della più alta concentrazione umana del pianeta: centotrentamila abitanti per chilometro quadrato.[…] L’aria era talmente impregnata di ossido di carbonio e di zolfo che l’inquinamento causava la morte di almeno un membro di ogni famiglia. La canicola pietrificava uomini e bestie per gli otto mesi dell’estate e il monsone trasformava stradine e catapecchie in laghi di fango e di escrementi. Fino a un passato recente, lebbra, tubercolosi, dissenteria e tutte le malattie da carenza riducevano la speranza di vita a uno dei livelli più bassi del mondo.[…] Ma la Città della gioia era soprattutto un luogo dove imperversava la più estrema miseria economica. Nove abitanti su dieci non avevano una rupia per comprarsi trecento grammi di riso”.
Il termine inglese slum comprende il significato tradizionale di aree residenziali che in passato erano rispettabili o persino attraenti, ma che col tempo si sono deteriorate a causa dell’abbandono degli abitanti originali emigrati verso nuove e migliori aree della città. La condizione delle vecchie abitazioni è degenerata e le unità abitative sono state progressivamente frazionate e affittate a gruppi a bassa rendita. Un esempio è quello degli slum nei centri di molte città storiche sia di paesi industrializzati sia in via di sviluppo. In italiano tale significato può somigliare a quello di bassifondi, baraccopoli o ghetti. In genere l’espressione di questo termine è venuta a includere anche i vasti insediamenti informali che stanno rapidamente divenendo l’espressione più manifesta della povertà urbana. La qualità degli alloggi in questi insediamenti varia da semplici baracche a strutture permanenti, in cui i servizi primari come acqua, elettricità, servizi igienici e altre infrastrutture e servizi di base sono pressoché limitati.
La creazione degli slum è strettamente collegata ai cicli economici, le tendenze nella distribuzione nazionale del reddito e, negli anni più recenti, alle politiche nazionali di sviluppo economico. Secondo il rapporto, la natura ciclica del capitalismo, l’aumentata domanda di mano d’opera specializzata contro quella non specializzata e gli effetti negativi della globalizzazione (in particolare i boom e i fallimenti economici che hanno gradualmente aumentato la disuguaglianza e distribuito nuovo benessere in modo irregolare) hanno contribuito all’enorme aumento degli slum. Lo sviluppo degli slum è sostenuto dalla combinazione di una rapida migrazione dalle aree rurali verso le città, una vertiginosa crescita della povertà urbana, l’incapacità per i poveri delle città di accedere a prezzi sostenibili a terreni dove stabilire un alloggio e il possesso non garantito delle terre occupate.
Esiste il “nostro” design, quello che viene pensato, progettato, realizzato in cicli produttivi, criticato e diffuso. Esiste poi un design che nasce per bisogno, in un mondo a noi distante che quasi non conosciamo: è quello dei paesi poveri. La mostra “Made in Slums. Mathare Nairobi” in corso alla Triennale di Milano fino all’8 dicembre 2013 racconta, dopo le esperienze di Cina, Corea e India, le esperienze dei territori più degradati della progettazione internazionale.
La protagonista del design è Mathare, una baraccopoli poco distante da Nairobi, che conta circa 500mila abitanti, in cui la genialità della comunità sopperisce alle mancanze del territorio con un originale processo di autoproduzione di oggetti d’uso quotidiano, utilizzando materiali del luogo e di scarto.
Il progetto della mostra è nato con il coinvolgimento del designer Francesco Faccin in un progetto di cooperazione dell’ONG “Liveinslums” atto allo sviluppo attraverso la realizzazione di attrezzature e arredi di una scuola con materiali e mano d’opera locale.
In questo luogo, racconta il curatore della mostra Fulvio Irace, «come nell’isola di Robinson Crusoe, lungo le frontiere di una spiaggia virtuale, la marea deposita gli scarti della capitale: pezzi di legno, insegne pubblicitarie, tavole, lamiere e soprattutto bidoni, l’elemento base di un progetto di riciclo minuzioso ed efficace». Da qui nasce un’industria informale, imposta dalla necessità e dalla povertà, in cui nemmeno chi crea l’oggetto sa che potrebbe trattarsi di un manufatto di design. E invece anche questo è design, quello fatto di forme giustificate e migliorabili, dotate di una forza misteriosa e senza regole; gli oggetti sono contemporanei, ma allo stesso tempo rivelano un carattere antico, sono seriali, ma discendono da una tradizione primitiva. Un design povero, dunque, ma ricco di creatività.
 Tutti i prodotti sono pensati per una filiera piccola e corta, che si vende e si consuma nello stesso luogo.
Tutti i prodotti sono pensati per una filiera piccola e corta, che si vende e si consuma nello stesso luogo.
L’esposizione è allestita, oltre che dagli oggetti anche da una serie di video che mostrano le fasi realizzative dei vari manufatti, il reportage sulla costruzione di una scuola realizzata in terra cruda, tecnologia locale e rurale che apporta i benefici di economicità e frescura dei locali, nonché la realizzazione dell’argine di un fiume, per proteggersi dalle piene ed evitare l’erosione del suolo.
Gli oggetti esposti, nel complesso, sono riconducibili alla semplicità e funzionalità, che lo svolgimento delle ordinarie attività quotidiane, necessita:
– Chicken feeder, oggetto pensato come distributore “automatico” di cibo per galline, realizzato in lamiera piegata e verniciata, in cui il becchime cala di livello a mano a mano che viene mangiato;
– Mukokoteni, un carrello a tre ruote per venditori ambulanti, solitamente usato per la vendita di uova e salsicce;
– Mtengo ya mtandao, una trappola per topi creata con rete metallica di recupero, elettrosaldata, in lamierino metallico;
– Chungu, una pentola realizzata da lastre di alluminio antiscivolo industriale, spesso recuperato da auto safari;
– Benki, scatola in lamiera usata come “salvadanaio”, solitamente per i soldi necessari per il funerale di un familiare;
– Akala shoes, sandali ottenuti dalla gomma di copertoni;
– Thong, ferro arricciacapelli realizzato tramite forgiatura del ferro;
– Yamafuta, brocche ricavate da tubi di grondaia.
L’ingegnosità e la creatività di queste “comunità slum” sorprende e affascina, ma al contempo contrasta fortemente con le società e le realtà occidentali, ricche e per certi versi opulente, in cui il prodotto serve più spesso a soddisfare bisogni pressoché consumistici che necessità quotidiane e reali.
di Annamaria Rivolta
Linkografia:
http://it.wikipedia.org/wiki/Disegno_industriale
http://design.repubblica.it/2013/09/26/creativi-per-necessita/
http://www.massacritica.eu//?s=slum+di+calcutta&x=9&y=6
Bibliografia:
“La città della gioia” di Dominique Lapiere.