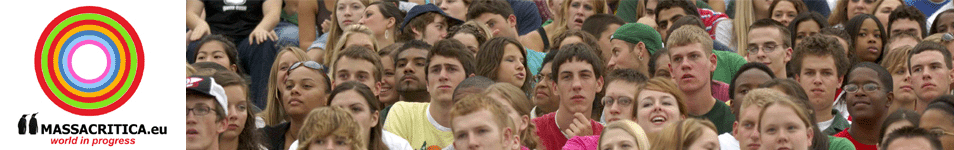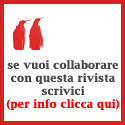Medea era una fanciulla di nobili natali, erede del dio Sole, educata alle arti magiche, dipintaci come sporca infanticida, fragilmente spietata. Tragico. La tragedia di Medea parte dall’ira, dalla ferocia del tradimento.
Euripide e Seneca nel parlare della figura della strega, barbara e assassina, venuta dalla Colchide con la nave Argo, giungono a risultati diversi pur partendo dal medesimo ceppo, quello del rancore.
Facciamo un passo indietro. Pensiamo ad un uomo, greco, quindi fiero portatore di una cultura che si affermava indiscussamente come superiore in tutto il mondo antico. Gli altri popoli non avevano cultura, erano solo i non greci, i barbari, privi di regole e di lingua propria. Partiamo dunque da un uomo valoroso, al pieno della forza fisica ed abbastanza giovane da vestirsi di quella sfrontata arroganza dell’onnipotenza.
Tutto poteva Giasone, quando a guida degli Argonauti partì alla ricerca del vello d’oro. La brama di vendetta e potere guidarono il suo animo, desideroso di tornare in possesso del regno paterno, a Iolco, usurpato dallo zio Pelia. Giunto in Colchide, Giasone conobbe la strega – principessa altera, figlia del re Eete – e da quell’incontro di forza nacque l’amore e con esso un tragico destino.
La forza di Medea e la sua crudeltà caddero dunque a pezzi di fronte alla passione. L’intoccabile arte magica, la superba freddezza, onorevole e tremenda, cedettero il passo di fronte a quello che, secondo i parametri greci, era un immenso e insuperabile limite: la femminilità. Essere donna è la più grande disgrazia di Medea e dall’ineluttabile destino di ogni donna di quel tempo – il matrimonio e la maternità – nascerà la sua tragedia.
Cosa poteva essere infatti una fanciulla, un tempo, per un uomo forte e bello, venuto da lontano in terra barbara e straniera? Un delicato gingillo, un grazioso contrattempo, un intrattenimento fugace. Medea però aveva la grazia delle donne e la veemenza di un uomo. Era scaltra, forse malvagia, appassionata. Aiutò Giasone a superare le prove per recuperare il vello d’oro e salì sulla nave Argo come sua pari, scegliendo la propria sorte e non arrendendosi al destino che le era stato prospettato.
Medea lasciò la Colchide, la patria, la casa paterna; fece a pezzi il fratello pur di conquistarsi il privilegio maschile per eccellenza: la scelta, la libertà. Per capire i meccanismi del complesso rapporto sociale tra uomini e donne bisogna però abbandonare, lungo la strada, tutti i riferimenti e i valori moderni a cui il mondo occidentale contemporaneo è abituato. La donna e l’uomo nelle civiltà antiche erano su piani distinti, totalmente separati, come uomini e dei. Ognuno doveva limitarsi a fare la propria parte, senza mischiare i dadi. Che effetto avrebbe potuto dunque avere sulla comunità una donna ribelle – maga, per giunta – che rivendicasse per sé diritti come un uomo? Quale sarebbe stata una possibile reazione? Guai terribili possano cogliere quella donna che, a torto, abbia osato mettersi sullo stesso piano di un uomo! Giasone portando con sé Medea, l’accolse in casa come sposa, come madre dei propri figli, ma giunti in Grecia la ripudiò in nome di nozze regali con Creusa, figlia del re, riducendo l’infelice all’esilio.
Era comune che un uomo abbandonasse la propria donna senza meritarsi ignominia. Giasone infatti non fu né il primo né l’ultimo greco a compiere una scelta simile. Le spose, le madri, le donne sapevano perfettamente che persino il loro ruolo nella casa era rimesso alla volubile scelta di un uomo. Nessuna di loro avrebbe osato ribellarsi, perché la donna antica stava sempre al proprio posto, in città, nella casa, nel talamo e non è detto che in questo posto non si sentisse bene, protetta e non necessariamente costretta.
Medea però voleva arrivare a toccare il sole da cui era nata; non poteva accettare un rifiuto, non poteva arrendersi all’abbandono, non poteva sorridere a Giasone o perdonarlo. Non poteva, in sintesi, ridursi a fare la donna. Non c’è scampo per chi non accetta il proprio destino, la propria moira, ed Euripide nel dipingere il personaggio di Medea raffigura bene la sua altalenante corsa, l’alternarsi scoordinato tra arroganza e fragilità. Medea non vuole essere una donna, rifiuta la sua sciagura, non può permettersi di accettare il ripudio di Giasone, ma proprio questo tentativo folle di negazione di se stessa, non fa altro che esaltare la sua emotività – emblema, un tempo, del mondo femminile – conducendola fino all’esasperazione. Proprio da questa danza sconnessa tra femminilità e mascolinità, tra accettazione e scelta, prende dunque le mosse la vicenda di Medea nella narrazione di Euripide e di Seneca.
Bisogna precisare però che – per quanto entrambi gli autori facciano scaturire la tragedia dal tradimento di Giasone – il sentimento descritto nelle due narrazioni assume sfaccettature differenti.
Chi è infatti Giasone per Medea? Euripide risponde deciso: il traditore, il nemico, l’usurpatore da distruggere e a cui far scontare vendetta. Seneca invece propone al lettore un quadro più complesso: Giasone ci viene infatti presentato innanzi tutto come l’uomo di cui Medea è stata innamorata e da cui in fondo, ancora, fatica a separarsi. Tanto più è forte l’amore per l’uomo, tanto più amaro il sapore del rifiuto e più cruda la vendetta. Seneca ci descrive Medea mossa dall’amore deluso, più che dall’orgoglio ferito. In quest’ottica i figli fatti a pezzi sono il simbolo estremo di quell’amore vilipeso e calpestato, troppo doloroso e amaro da avere a lungo sotto agli occhi. Medea trova la forza di uccidere i figli solo dopo aver avuto la conferma di quanto per Giasone essi siano cari, al di là del legame tra lei e il proprio uomo. Medea odia Giasone, ma non cessa di chiamarlo marito, di desiderare di tenerlo con sé.
Qui il rifiuto del modello femminile classico diventa paradosso, al punto da dare a Medea una leggerissima sfumatura di eroina romantica. Chi non può vivere un amore vive per distruggerlo, vendicarlo, macchiarlo di tragicità. Ed ecco che scivola fluido di fronte al lettore tutto il piano assassino della strega, come un nastro tra le dita. I doni avvelenati alla sposa usurpatrice – con cui verrà rasa al suolo sul nascere la futura progenie di Giasone – e infine l’estremo gesto, il coup de theatre: i bambini nati dall’amore diventeranno, di fronte agli occhi del padre, vittime sacrificali di quello stesso amore, tradito. Cancellate col sangue le tracce di tutto quel che è stato e che sarà, Medea vuole vedere Giasone solo e vagabondo passare la vita a rimpiangere quella stessa donna che ha osato disonorare. Medea condanna la ricerca da parte di Giasone di un matrimonio legittimo e regale, in nome del fatto che ella si è sempre sentita moglie, ancor più saldamente legittimata dall’amore viscerale che ha portato a generare figli, prova inconfutabile dell’autenticità del matrimonio con quello stesso uomo che, scegliendo un’altra donna, non si è mai sentito marito.
Dall’analisi della tragedia emerge dunque sottilmente come dietro al sipario terrificante del cruento matricidio vi sia malcelata anche la colpa di Giasone, in nome del quale Medea si è macchiata le mani di sangue. La modernità si fa strada dietro alla tradizione e, secondo questa interpretazione, uomo e donna tornano nuovamente alla pari, se non nell’amore, almeno nella colpa. Cosa rimane dunque di queste due figure, tanto piccole e disperate, quanto grandi nell’eccesso d’amore e di morte? Medea salirà sul carro del sole, macchiata del proprio stesso sangue, lontana dalla strage che ella stessa ha provocato e da Giasone, che alla fine appare alla scena come un semplice mortale sventurato, la cui gloria passata è solo un lontano ricordo. Pagherà a caro prezzo l’esser venuto meno al sacro giuramento d’amore e, perso il favore di Era, regina degli Dei, morirà solo e privo di onori. Persino Dante lo collocherà all’Inferno tra i fraudolenti, nella bolgia dei ruffiani e seduttori, per aver tradito la parola data e aver ingannato Medea, gettandola in disparte dopo aver estorto da lei aiuto e sacrificio.
Questo riferimento apre la strada ad un’ulteriore riflessione: cosa resta dopo il mito? Che destino hanno le macerie di una tragedia consumata? Fin ora abbiamo analizzato i personaggi della tragedia con occhi antichi, ma ci sono occhi sapienti che hanno provato a rispondere a queste domande, illuminando Medea e Giasone alla fioca luce del decadentismo. Cesare Pavese nei Dialoghi con Leucò riprende alcune figure della mitologia greca classica riportandole in una dimensione umana. Ci presenta i vari personaggi come in un acquario, separati da noi, ma allo stesso tempo smossi dalle nostre stesse angosce. Anche Giasone è stato collocato in una teca da Pavese, liberato dalla magnificenza del suo passato di Argonauta, ma vecchio e stanco, seduto in disparte, intento a lasciarsi raccontare il mondo alla finestra da una piccola servitrice del tempio. Nulla resta dell’autorità di uomo greco pieno di onore e vigore e persino il ricordo di Medea sembra ai suoi vecchi occhi come un frammento vissuto in un’altra vita. Eppure c’è stato un tempo in cui lui e la strega si amarono, c’è ancora nella memoria un’immagine sfocata di quando lui e la madre dei suoi figli si appartenevano, ignari della rovina che si sarebbe abbattuta su di loro. Giasone racconta alla giovane Mèlita che abbracciando Medea credeva di avere tra le mani una dea che lo illudeva di essere anch’esso un dio; la portò con sé in patria, la rese madre, ma destato, come da un sogno ingannatore, guardandola negli occhi si sentì deluso, trovando di fronte a sé nient’altro che una donna. Le barriere tra presente e passato si rompono di getto e l’attenzione è riportata sul piano sentimentale, quotidiano, delle aspettative deluse.

Rimane dunque una pozza di rimpianto, in cui specchiarsi è tanto doloroso quanto accettare la propria sconfitta, più in là un fuoco divenuto cenere, due occhi pieni di domande persi oltre le nuvole e la notte che cala su un teatro vuoto, ma ancora agitato dall’eco di parole e grida.
di Maria Elena Micali