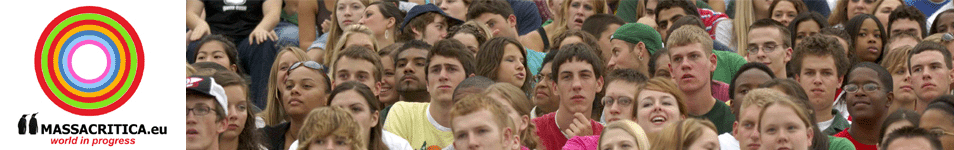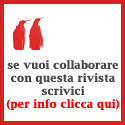Dentro la gabbia di risposte consumate
Nell’intensa resa scenica di Andrée Ruth Shammah, fallimento, meschinità e assenza di alternative compongono il quadro simbolicamente teso de “Il lavoro di vivere”di Hanoch Levin. Con quel senso di inadeguatezza che ci portiamo appresso. Tutti noi. Perché, senza incanti, la vita precipita in un baratro. Buio
Sono lì. Ancora lì. Insieme, ma soli. Terribilmente soli. Nel chiuso claustrofobico di uno spazio che avvolge come morsa soffocante. Sul piano scosceso ad ospitare un letto: un pò talamo, un pò nicchia. Nido. Il mondo è fuori, intanto. Loro, incuranti, o quasi, affianco. Lo srotolarsi vorticoso di una vita alla ricerca di senso, nell’itinerario tortuoso di una condizione esistenziale votata a consunzione e sconfitta, sembra che non li sfiori. E, invece, fagocita entrambi. In una palude malmostosa. Una “pozzanghera”. Sono ancora lì. A dilaniarsi, a stracciarsi vesti e brandelli d’anima, a ferirsi, nel gioco infinito di un massacro che ne preannuncia ancora un altro più sanguinoso. Definitivo, forse. I fendenti non si contano, come le ferite. I colpi bassi, vendicativi. Le parole sputano fuoco. Schiumano rabbia. Rancorose. Intinte nel vetriolo del sarcasmo delegittimante. Il lettone, allora, si trasforma presto in un’arena grondante astio, un vero e proprio ring dove i percorsi di una vita coniugale si intrecciano per poi deragliare. Ripicche, critiche, accuse sferzanti, nel gioco della reciprocità deprivata di rispetto si rincorrono, affastellandosi una sull’altra in una torre babelica di frustrazioni montanti. Nella notte della verità, tutti hanno ragione, nessuno ha torto. Da una parte, lui. Dall’altra, sotto una coltre di bianche lenzuola, lei, a sognare. Yona Popoch, all’attacco, feroce, e sua moglie Leviva, in difesa. Coppia di mezz’età, incamminata sul binario morto dell’incomunicabilità. Il rapporto tra i due di natura patologica, ormai, per raggiunta saturazione dopo trent’anni di malcelata sopportazione, ha risvolti cruenti sul filo di una storia quasi svuotata di storia che, annegata nel nulla, angosciosamente, riflette la riaffiorante drammaticità di una crisi tutta maschile (ma non solo). E, gli insulti proliferano, vomitati da una deriva esistenziale, che nasconde motivazioni reali (consce), ed altre, profonde, affondate nell’inconscio. Il marito, a lei: «stupido animale», mentre rovescia il materasso e la moglie stessa. Di rimando, in difesa accanita ma resistibile, il riferimento al «pene invecchiato», appare timida reazione, inutile ripicca. La “pozzanghera” appare prosciugata. La moglie, persa a sognare i suoi cappellini estivi, tenta un impossibile recupero, pescando nel serbatoio dei ricordi comuni più belli, nel vacuo trascinare l’ostinatezza del marito sul piano della quieta ragionevolezza, per acuire, poi, quei caratteri di mediocrità banale e ordinarietà di una vita intera senza sogni (e, forse, progetti). Scivolare nella voragine del cinismo è un attimo. Ruvido. Inevitabile. Il fastidio cresce, l’insofferenza pure. Sotto la coperta troppo corta (o il lenzuolo, bianco e neutrale?!?) di parole rosso fuoco, scostanti, incanalate in un mix di amore e odio, morbosa simbiosi di fastidi e repulsioni, Yona avverte l’intimo bisogno di approdare ad un lido di diversa natura. Deciso ad andarsene, mentre infila un vestito stazzonato sul pigiama. Frettolosamente. Con il cappello di sghimbescio. Agogna una libertà dalla schiavitù esteriore e interiore. Pur tra emozioni e conoscenze personalissime, paure e fughe, performance sessuali obbligate, accanite resistenze e ridondanze di uomo virato al grigio ed ebbro di narcisismo, la voglia di fuga si fa concreta nella sua improbabile realizzazione. Come quella di vivere. A dispetto del ‘lavoro’ che cancella le intermittenze del cuore e indirizza la vita su altri sentieri. Quelli di una morte cercata, inseguita in maniera disperatamente vitale.
Nel cuore della notte. Alle due. Mentre fuori la tempesta tonitruonante infuria. Ben dentro quella stanza forzatamente chiusa, senza pareti, immersa nel buio dell’insensatezza, cioè della mediocre normalità di ‘anime in pena’. Una sorta di prigione nella quale, Yona, rincorre il desiderio (ahilui, frustrato) di trasformarla e crederla un rifugio di libertà, come farebbe ogni recluso nel dimostrare di poter sorvegliare se stesso, proprio quando l’ebrezza del non essere condizionati e legati da/ad alcunché diventa fremito. Ruoli, condizionamenti, imposizioni si mescolano. Con il nulla (‘platonico’?) a permeare il desiderio, a rendere irresistibile l’appetito e insoddisfacente il piacere. Ma scivolato, ormai, negli abissi del nulla, incapace (meglio, indisponibile) com’è a sondare l’Acheronte della propria anima, nel delirio bofonchiante di onnipotenza/impotenza di una nevrosi paralizzante in cui crede di potere tutto (salvo poi non concludere niente), quest’uomo a metà, nello schivare la complessità dell’essere, finisce per rinnegare la comprensione profonda che lega (o dovrebbe) un uomo e una donna, dentro il cammino di complicità e spiritualità alta. La prosa della vita, probabile assai, ridimensiona gli ideali. Tarpa loro le ali.
Con la goccia stillante, in bagno, a cadenzare, nella sua inarrestabile caduta ritmata, il trascorrere inesorabile del tempo, eppoi, dell’immanente vecchiaia, gorgo profondo della caduta di illusioni e sogni infranti, prossimi a introiettare la morte. Per un attimo, i rancori sembrano assopirsi, l’astiosità tignosa arretra. Le lusinghe, carezzevoli: un ricordo. La vita era lì, bella e seducente. Con le sue promesse pedanti, forse; ma le scommesse, si sa, vivono di futuro (ah, Pascal, Pascal…). La folgorazione passa, mutua in paciosa consuetudine come ardore della contingenza, assai distante, però, dal colorare i sogni. Il lamento di Yona è borbottìo indistinto. «Il mondo apparecchiato per me, si sbriciola, va in frantumi. Come? Perché? E, dopo, le solite «domande consumate per risposte consumate. Solo il mio dolore non vuole saperne di consumarsi». Un ghigno reso feroce dall’ineluttabilità di una vita insoddisfatta. Fino ad affacciarsi (perché costretto) alla finestra, davanti ad un orizzonte ingrato, ostico e ostile. “Il solo modo per superare il conflitto è viverlo”, sembra suggerire in un cantuccio Dürrenmatt. Yona, raccoglie. Tra macerie abitate da vite svuotate, all’interno di uno spazio che da fisico, diventa drammaturgico e viceversa, nel gioco a rimbalzo di un metateatro rinchiuso in scatole cinesi. Un mondo parallelo, concepito dall’autore (il sulfureo, squassante Hanoch Levin, ebreo, israeliano), capace di risucchiare gli incauti, ma anche delineato attraverso la scrittura, perché l’arte, la letteratura, strumenti elitari per confrontarsi con il mondo, ne consentano di intravederne il senso. I fantasmi del vuoto esistenziale si fanno presenze, impalpabili ma certe, alla luce tremolante delle candele di Leviva. Sì, quando il sole è già sparito e compaiono le prime tre stelle, s’intravede il rito di catarsi collettiva giunto alla conclusione che schiude allo Shabbat, il giorno del riposo settimanale fino al tramonto del sabato. Forse. Ma in questa notte senza stelle le vibrazioni tra universalità e particolarità scompaiono. Così come le scelte di donna ferita, impastate di pragmatismo e sentimento perdurante, davanti al muro invalicabile che le si para davanti. Yona è determinato. Una disperata legittima difesa, la sua, che va continuamente a scapito della veridicità, immancabilmente.
La grinta inventiva, le cupe dinamiche conflittuali, la misura del grottesco, tornano puntualmente a intrecciarsi in una prodigiosa visionarietà romanzesca. Con un testo incardinato nella trama di una deriva esibita senza remore, pronta ad assumere prismaticamente i toni angosciosi del tragico, per trasmutare, quasi fosse un cocktail bizzoso, in quelli del leggero e del comico, scostante, però. Nell’intimità della Sala 3 del Teatro Franco Parenti, davanti a piccoli spalti tripartiti, assorti in un silenzio muto, partecipe, a seguire sviluppi imprevedibili, con quella sorta di ponte-talamo a calamitare l’attenzione curiosa di chi spia voyeuristicamente attraverso le feritoie di veneziane (in)discrete, tanto che il coinvolgimento accomuna gli spettatori nello stesso modo in cui cattura il protagonista Yona e sua moglie Leviva. I quesiti, usurati dal tempo inesorabile, si aggrovigliano: se i rapporti intimi ci sprofondano nello scetticismo, cosa ci resta? È possibile salvare brandelli del passato per riscattare il presente? Davvero? E quando tutta l’esistenza sembra negare la morte, come la si può accettare? Tutti tasselli di una dimensione infarcita di riferimenti precisi. Gli echi, lontani, strinberghiani e beckettiani, con un pizzico di Pinter, un briciolo di Brecht, ed una ventata corrosiva alla Bernhard, risuonano sinistri. Assieme (perché no) a Santanelli, Lunari. Spazi, come prigione dell’anima. E, il soffio kantoriano a sibilare sinuoso, negli interstizi di presente e passato, vita e morte, quindi, tra strazio angosciante e divertimento, in una ciclica reiterazione (non solo verbale) di gesti e situazioni conficcate nell’interiorità di chi vi assiste. La parola, allora, si trasforma in aratro filosofico, e con esso trascina la pietà sul piano di una sottile crudeltà, lo sbuffo ilare che diventa sarcasmo, la pietà a rivestirsi di crudeltà ed il cinismo, in agguato, a sciogliersi in lacrime. La semplicità scarna delle battute ed il loro contenuto dimesso, rivolto ai piccoli fatti quotidiani privi di eroismi e impastati soprattutto di tragedia, veicolano il testo dell’odiosamato Levin (autore mirabilmente prolifico, prematuramente scomparso, apprezzato all’estero ed osteggiato in patria per posizioni anticonformistiche e, a volte, radicaleggianti) verso le praterie abitate da divertimento feroce e strazio sottile. Dimensione in cui disperazione, brutale franchezza, ironia, e scardinamento della falsa morale, sembrano danzare insieme grazie all’incisività di una messinscena calibrata sul ‘nulla’, sì, certo, ma un nulla ricchissimo di suggestioni e messaggi sottesi. Ecco, perché Andrèe Ruth Shammah, con fine, defilata sagacia, nell’equilibrio precario di una situazione sfuggente, riesce a restituire tutta l’energia rappresa in parole sospese. Sul filo teso di una tensione ad altissima drammaticità. «Paradossalmente allegra». E se è vero che Levin e l’appassionata regista si muovono all’interno di una cultura ben connotata, quella ebraica, là sullo sfondo (sorvolando su aspetti specifici della situazione mediorientale, assenti nel testo), pur tuttavia la risonanza (in controcanto) delle tematiche investe gli spettatori, tutti noi. Se una vita non ha una destinazione etica, che valore ha? Rimane solamente una serie di accadimenti biologici e pratici? Svuotati di ratio?
Il senso del vuoto, la perdita, il baratro incombente, la pena, la necessità di trovare la propria via d’uscita, sembrano individuare un disagio la cui origine non è psicologica ma culturale, non riguarda il singolo individuo ma la massa (non passiva), con quell’incapacità sia religiosa che della semplice “ragione” a far da barra stabilizzatrice dei rapporti fra gli uomini. Il nodo di libertà collettiva e libertà individuale, si aggroviglia. Inscindibilmente. Quel progetto etico-giuridico, sì, dell’ebraismo, allora, pare premiare la supervalutazione del valore della vita. Probabilmente, Yona tralascia (in)consciamente la traccia della Torah (nel Deuteronomio) davanti a vita e morte, quando questa, nel sottolineare l’architrave di regole e precetti prescritti all’ebreo, si prefigge il solo scopo di santificare la vita. Nemmeno l’irruzione (vista la luce accesa) dello spaurito, improvvido, Gunkel (uno straniato, misurato nella dismisura, Massimo Loreto), alla ricerca di accoglienza e calore umano, col misero pretesto di un cappello da farsi restituire, “obbliga” a placare l’animosità dei “contendenti”. Eppure, alla fine, è la paura di rimanere soli, il timore di confrontarsi con l’esterno, rifuggendo dal misurarsi con un ignoto irraggiungibile, a prevalere. Yona si rincantuccia in angolo. La solitudine è totale. Il rituale del crudelissimo gioco vittima-carnefice lo ha sfibrato. Ammette, però, di essere ancora legato alla moglie, causa della sua deriva. Ovidio, in controluce, riaffiora: “nec sine te nec tecum possum vivere’’. Il rapporto tra i due, in bilico sulle note di un valzerino esistenziale, caratterizzato dall’incapacità di mantenere una relazione affettiva sana e contemporaneamente dall’impossibilità di separarsi definitivamente, si fa ipotesi concreta. Ma il distacco, la mancanza dell’altra, come opzione per risolvere la questione della incompatibilità, precipita nella voragine nera (delle paure) senza appello. Spaventa. E, così, lui, il marito, incapace di affrontare le piccole e grandi questioni della vita, desiste. Rinuncia alla fuga. Sino agli esiti fatali di un destino annunciato.
Proprio quando, nell’imperdibiltà di una messinscena ‘altra’, seducente (corroborata dalla scena in sospensione precaria di Gianmaurizio Fercioni e dalle luci tremule di Gigi Saccomandi), il quadro interpretativo, d’altissimo lignaggio, va a ricomporsi. Yona ha le movenze rallentate del fallimento frustrato di un assorbente Carlo Cecchi. Tignosamente perfido, inghiottito da borborigmi mentali ed esistenziali, offre, restio, la linearità di un gesto scenico permeato di essenzialità. Distanziazione ma non distacco. Anzi, interiorizzazione. Una dimensione, nella sua prismaticità scintillante di sfumature minimaliste, abitata da uno spaesamento nichilista, accettato come “il più inquietante fra tutti gli ospiti” (Nietzsche, Nietzsche, sì). Cecchi, nel suo dire stancamente strascicato, veicola suggestioni. Il pensiero, il suo, allora, nella stanza chiusa, abitata da fantasmi, diventa quello di un musicista jazz che improvvisa un nuovo riff. Tra leggerezza e note dolenti. ‘Suona’ da solo, è vero, con uno strumento che anche altri potrebbero suonare, però. Improvvisazione individuale jazzistica, immersa in una matrice socioculturale: ecco, il pensiero umano. Unicità d’attore. Diverso. Capace di misurarsi con la determinazione ostinata (tutta sveva), la passionalità intonsa (spagnoleggiante) e quel senso sparso di fatalismo (arabo), che intride la prova di una volitiva, accogliente, Fulvia Carotenuto. Brava. Mediterranea. La sua Leviva è ancora innamorata. Ma, «Ci resta ancora da invecchiare insieme», si perde nel vuoto. “Dalle lacrime, pensieri”. Il Kaddish (o quasi, evocato) la preghiera per chi scompare, trascina con sé il dolore, ma anche la possibilità di riflettere su di esso, quasi per controllarlo e superarlo. Dopo fallimenti e privazioni, scomparse e assenze di alternative. Ecco, il pianto sgorga felice, perché la compassione è un sentimento da riconquistare. Disperatamente. Nella notte buia. Dentro la gabbia. Dove anche le domande, oltre che le risposte, sono consumate.
di Franco Bruno
Teatro Franco Parenti – Milano – fino al 21 dicembre 2014
“Il mestiere di vivere” di Hanoch Levin-uno spettacolo di Andrée Ruth Shammah
con Carlo Cecchi, Fulvia Carotenuto, Massimo Loreto